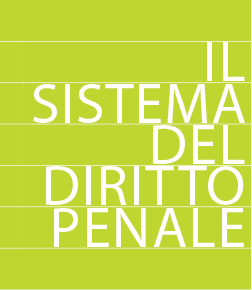Proroga del regime carcerario di cui al 41-bis: il confine tra tutela della salute umana e rispetto delle necessità detentive.

CEDU, 10 aprile 2025, Morabito c. Italia.
IL DISPOSITIVO
“Considerata la finalità preventiva e di sicurezza del regime di detenzione di cui all’art. 41-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354, si afferma la responsabilità dello Stato per violazione dell’art. 3 della Convenzione e, segnatamente, del divieto di trattamenti inumani e degradanti, dato il mantenimento del ricorrente in tale regime nonostante il progressivo deterioramento neurocognitivo che esclude che il detenuto sia ancora in grado di rappresentare un pericolo conservando un contatto pratico significativo con l’organizzazione criminale di provenienza.”
IL CASO
Il ricorrente è stato condannato in quanto esponente di spicco di un’associazione di tipo mafioso e ristretto ai sensi del regime dell’articolo 41-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354. Il ricorrente lamenta l’incompatibilità del suo stato di salute sia con la prolungata detenzione che con il regime di “carcere duro”. Egli, infatti, risulta affetto da numerose patologie tra le quali un progressivo deterioramento neurocognitivo.
Il Governo ha fornito il diario clinico del ricorrente relativo all’intero periodo della sua detenzione in carcere, dal quale emerge che egli aveva assunto numerosi farmaci, era stato visitato regolarmente dai medici in servizio ed era stato sottoposto a diverse visite mediche da parte di specialisti in vari ambiti. In generale, le condizioni del ricorrente sono state descritte come moderate o stabili nella misura ragionevolmente attendibile, vista l’avanzata età del detenuto, e comunque compatibili con la detenzione in carcere.
Con la prima doglianza, il ricorrente lamenta che non avrebbe dovuto permanere in carcere a causa della sua età avanzata e delle numerose malattie croniche diagnosticategli.
Il Governo, da parte sua, pur riconoscendo che il soggetto era affetto da varie patologie, ha sostenuto che nessuna di queste presentava carattere terminale o risultava particolarmente acuta, invalidante o pericolosa per la vita del detenuto e che le cure somministrate, nonostante le affermazioni del ricorrente riguardo a specifiche carenze, erano state adeguate e sufficienti.
Con la seconda, il ricorrente sosteneva che la proroga del regime di cui all’art. 41-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354, alla luce del progressivo deterioramento delle sue facoltà cognitive e del suo precario stato di salute, fosse ingiustificata e costituisse un trattamento inumano e degradante.
Il Governo ha sostenuto che la proroga del regime dell’articolo 41-bis era giustificata, in quanto i Tribunali nazionali avevano tenuto conto del decadimento cognitivo del ricorrente prima di concludere che esso non aveva influito sulla sua persistente capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione criminale cui apparteneva. Secondo questi, infatti, le caratteristiche del soggetto e il suo comportamento prima e durante il periodo di detenzione facevano ritenere che il detenuto continuasse a rappresentare un pericolo.
LA QUESTIONE
La causa concerne l’asserita incompatibilità dello stato di salute del ricorrente con il proseguimento della sua detenzione in carcere, le cure mediche prestategli, e il proseguimento della sua sottoposizione al regime speciale di detenzione previsto dall’articolo 41-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354, nonostante il suo progressivo deterioramento cognitivo.
LA SOLUZIONE
Questa sentenza riafferma l’importanza di una valutazione regolare delle condizioni di detenzione, in particolare per i detenuti anziani con gravi problemi di salute, e sottolinea la necessità che eventuali restrizioni siano giustificate da motivazioni dettagliate e convincenti.
In ordine alla prima doglianza, la Corte ricorda come sia stato più volte affermato che l’art. 3 della Convenzione EDU che proibisce in termini assoluti la tortura, le pene o i trattamenti inumani o degradanti, indipendentemente dalle circostanze e dal comportamento della vittima, sancisce un obbligo di tutela della salute e del benessere dei detenuti in particolare proprio attraverso la fornitura di cure mediche adeguate. Nell’esaminare se la detenzione di una persona malata sia compatibile con l’articolo 3 della Convenzione, la Corte considera: a) lo stato di salute del detenuto e l’effetto su di esso delle modalità di esecuzione della detenzione; b) la qualità delle cure prestate; c) se il ricorrente debba o meno continuare a essere detenuto in considerazione del suo stato di salute.
Incontestate le patologie croniche di cui soffriva il ricorrente, la Corte rileva come nel periodo interessato tali condizioni non solo non abbiano registrato segni di particolare aggravamento ma che non vi sia alcuna indicazione che suggerisca che il regime speciale di detenzione abbia reso meno agevole a questo l’acceso alle cure necessarie o che abbia in qualche modo inciso sulle sue malattie.
La Convenzione non prevede alcun obbligo di scarcerazione per motivi di salute, anche se il soggetto è affetto da una patologia particolarmente difficile da curare. Tuttavia, in casi particolarmente gravi possono verificarsi situazioni in cui la corretta amministrazione della giustizia esige misure umanitarie. Gravi casi che, invero, non ricorrono nel caso di specie viste le rilevanze probatorie già sopra esposte e l’esame motivato e dettagliato che le istanze del detenuto avevano già trovato da parte dei Tribunali nazionali coinvolti.
Da tutto ciò la Corte ritiene che il mero proseguimento della detenzione non abbia costituito un trattamento inumano o degradante e che non vi sia stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione a tale riguardo.
In ordine alla seconda doglianza la Corte si dice non nuova al riconoscimento che considerazioni di ordine pubblico possono indurre uno Stato a introdurre regimi di detenzione di massima sicurezza per particolari categorie di detenuti. Sebbene questo non violi, in sé, l’articolo 3 della Convenzione, lo Stato deve garantire un livello adeguato di benessere e salute e che le persone siano detenute nel rispetto della loro dignità umana e che non siano sottoposte a sofferenze di ordine superiore a quelle inevitabilmente, ontologicamente connesse con la detenzione stessa. Ribadendo le finalità prettamente preventive e di sicurezza della misura di cui al citato art. 41-bis, volto com’è a recidere i legami e i contatti tra i detenuti e le organizzazioni criminali dalle quali provengono, la Corte di Strasburgo riconosce che, malgrado le autorità nazionali abbiano specificamente argomentato in merito alle ragioni secondo le quali il ricorrente continua a rappresentare un pericolo, la documentazione medica portata davanti alla stessa induce a dubitare legittimamente di tale pericolosità. Le verificate diminuite capacità cognitive del detenuto e i progressivi peggioramenti che queste hanno subito nei periodi successivi alle analisi del Tribunale di sorveglianza, ad avviso della Corte, rendono incompatibile la situazione di questi con la prosecuzione del regime di cui all’art. 41-bis citato. Non solo tale restrizione avrebbe potuto potenzialmente accelerare il decadimento cognitivo, ma risulta anche difficilmente credibile che una persona in tali condizioni possa riprendere o mantenere contatti significativi con un’organizzazione criminale ad un’età così avanzata, e dopo un periodo quasi ventennale di carcere particolarmente restrittivo.
La Corte ritiene, dunque, che sul punto vi sia stata violazione dell’art. 3 della Convenzione, e che tale constatazione sia sufficiente a risarcire il danno non patrimoniale subito.
Tali conclusioni non sono state accolte da uno dei giudici partecipanti.
La parziale dissenting opinion si appunta sulla affermata incoerenza di questa decisione con la pronuncia CEDU, 25 ottobre 2018, Provenzano c. Italia, il cui principio di diritto permette di rinnovare il regime speciale di detenzione pur in presenza di un confermato decadimento cognitivo, a condizione che – come è nel caso di specie avvenuto – le autorità nazionali, dopo un attento esame della documentazione medica, abbiano svolto una valutazione indipendente e siano giunte alla conclusione motivata che non si possa escludere il rischio di perduranti contatti con l’organizzazione criminale di provenienza.
Nota a cura di Davide Venturi