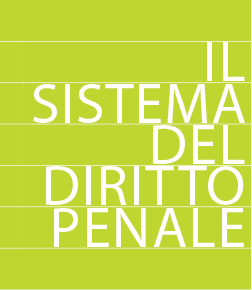Procedibilità a querela e reati connessi: è parzialmente incostituzionale l’art. 85, comma 2-ter del c.d. “Correttivo Cartabia”

Corte cost., 9 giugno 2025, sentenza n. 123
IL DISPOSITIVO
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in quanto richiamato dall’art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui prevede che si continua a procedere d’ufficio per il delitto previsto dall’art. 612-bis del codice penale connesso con il delitto di cui all’art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen., i termini previsti dall’art. 85, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale.
IL CASO
Nel giudizio principale, il Tribunale rimettente era chiamato a giudicare, con rito ordinario, della responsabilità penale di un imputato accusato di aver ripetutamente minacciato e insultato la persona offesa e di averne danneggiato la macchina, rompendone i tergicristalli, tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.
La persona offesa rimetteva successivamente la querela presentata contro l’imputato; tuttavia, i fatti risultavano procedibili d’ufficio poiché gli atti persecutori erano connessi al danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede, reato, all’epoca, precedibile d’ufficio.
Posto che a seguito dell’entrata in vigore del “correttivo” alla riforma Cartabia (il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 recante le “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 di attuazione della legge 27 settembre 2021 n, 134 “delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) nella primavera del 2024, anche il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede era divenuto procedibile a querela, la questione sorge in quanto l’art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 31/2024 prevede che questo mutamento del regime di procedibilità non abbia effetto, tra l’altro, su quello degli eventuali delitti di atti persecutori connessi al danneggiamento, che resterebbero, così, procedibili d’ufficio. Conseguentemente, il giudice si trovava nell’impossibilità di prosciogliere l’imputato, come da concorde richiesta delle parti, nonostante l’avvenuta remissione della querela da parte della persona offesa e ravvisava il contrasto della disciplina con l’art. 3 Cost. sotto due distinti profili: l’assenza di adeguate ragioni giustificative di detta deroga al generale principio di retroattività della lex mitior e l’irragionevole disparità di trattamento tra i casi i cui delitti previsti dagli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter c.p. siano connessi a reati divenuti perseguibili a querela in base al d.lgs. n 150/2022 e i casi in cui essi siano connessi a un delitto di danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede divenuto perseguibile a querela in base al successivo d.lgs. n. 31/2024.
LA QUESTIONE
La Consulta è chiamata a valutare la legittimità della norma del Correttivo Cartabia che prevedeva la perpetuazione della procedibilità d’ufficio per i reati di atti persecutori connessi a delitti poi divenuti procedibili a querela.
LA SOLUZIONE
Premesso che il regime di procedibilità ha natura mista, sostanziale e processuale, in quanto la querela costituisce al tempo stesso condizione di procedibilità e di punibilità, la Corte, nel richiamare la giurisprudenza propria e di legittimità, evidenzia che le modifiche a detto regime sono sottoposte ai principi costituzionali regolanti la successione delle leggi penali nel tempo quali l’irretroattività delle modifiche in peius e la retroattività di quelle in melius, anche perché la querela è da considerarsi istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell’an e del quomodo di applicazione del precetto (v. Cass., Sez. Un. pen., sent. 7 settembre 2018, n. 40150).
Riguardo al caso di specie, la Corte esclude che la disposizione censurata si sarebbe limitata a chiarire una conseguenza già desumibile dalla disciplina previgente, poiché non è in discussione il caso in cui la procedibilità si cristallizza al momento iniziale del processo, permanendo per tutta la durata del rapporto processuale, bensì la diversa ipotesi in cui il delitto connesso, originariamente procedibile d’ufficio, divenga procedibile a querela in forza di una legge entrata in vigore successivamente al fatto.
Dunque, gli artt. 609-septies, quarto comma, numero 4) c.p., 612 bis, quarto comma, c.d., e 612-ter, quinto comma c.p., disegnano altrettante fattispecie normative complesse imperniate sulla connessione tra questi delitti e un altro delitto procedibile d’ufficio. Queste regole, derogatorie rispetto all’ordinario regime di procedibilità a querela dei delitti considerati, dispongono che, in presenza del presupposto della connessione con un reato procedibile d’ufficio, anch’essi vengano attratti, ossia si conformino, al regime di procedibilità d’ufficio.
Ne segue che il mutamento del regime di procedibilità del reato connesso per effetto di una legge sopravvenuta si riverbera anche sul regime di procedibilità dei tre delitti in questione (violenza sessuale, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) e, pertanto, la sopravvenuta procedibilità a querela del reato connesso fa venire meno le ragioni della (eccezionale) attrazione di detti reati al regime di procedibilità d’ufficio.
La Corte costituzionale, pertanto, nel ritenere fondata la questione in quanto l’art. 85-ter del d.lgs. 150/2022 – richiamato dall’art. 9 del dl.gs. 31/2024 – è irragionevolmente derogatorio rispetto all’ordinario operare del principio di retroattività della legge penale più favorevole entrata in vigore dopo la commissione del fatto, riafferma i due concorrenti fondamenti del principio: l’equiparazione del trattamento sanzionatorio di medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma che ha disposto l’abolitio criminis o la modifica mitigatrice (v. Corte cost., sentenza n. 236/2011) e il diritto dell’autore del reato a essere giudicato, e se del caso punito, in base all’apprezzamento attuale dell’ordinamento relativo al disvalore del fatto da lui realizzato, anziché in base all’apprezzamento sotteso alla legge in vigore al momento della sua commissione (v. Corte cost., sentenza n. 63/2019); diritto che richiama, a sua volta, la garanzia necessaria proporzione del quantum dello stesso an della reazione sanzionatoria rispetto al reato, secondo la valutazione del legislatore nel momento in cui la pena viene concretamente irrogata.
In definitiva, la disciplina censurata è dichiarata lesiva dell’art. 3 Cost. perché comporta un sacrificio netto dell’interesse dell’imputato che abbia commesso il fatto prima della modifica normativa a un trattamento uguale a quello di chi abbia commesso un fatto analogo dopo tale modifica, nonché del suo interesse all’applicazione di una disciplina che il legislatore reputa oggi proporzionata rispetto al complesso degli interessi in gioco e senza che tale sacrificio possa dirsi funzionale a tutelare controinteressi di rango costituzionale della persona offesa.
Nota a cura di: Valentina Riente (Funzionario presso l’Avvocatura regionale della Valle d’Aosta)