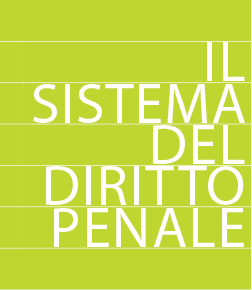La denigrazione gratuita, pregiudizievole della sfera morale della persona, non è scriminata dall’esercizio del diritto di critica

Cass. pen, Sez. V, 1 luglio 2025, sentenza n. 24274
LA MASSIMA
“L’esame della sussistenza degli indicatori dell’esercizio del diritto di critica, idonei a fondare l’operatività della scriminante, è stato anche più volte “relativizzato” ed affiancato, dall’esegesi giurisprudenziale corrente in tema di diffamazione, a quello del “contesto” nel quale le parole offensive siano state pronunciate o riportate, che viene comunque di regola ancorato al fenomeno “dialettico” della esposizione di pensieri ed opinioni, al tipo di concetto da esprimere, ferme restando – però – la necessità di un ragionevole collegamento a “fatti specifici” che non esulino da quella “base” di verità – inconciliabile, pertanto, con le accuse “generiche” – e l’invalicabilità del veto alle aggressioni personali e gratuite in pregiudizio della sfera morale del destinatario. Pertanto, il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può in alcun modo scriminare l’uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest’ultimo in quanto tale”.
IL CASO
L’imputato proponeva ricorso in cassazione avverso la sentenza d’appello con la quale era stata confermata la condanna a suo carico per aver, durante un comizio pubblico, rivolto pubblicamente espressioni offensive nei confronti del sindaco in carica, definendolo “ignorante”, “burattino” e insinuando una sua “connivenza mafiosa” nell’ambito dell’affidamento degli appalti per la gestione dei rifiuti urbani.
L’imputato- formulando un solo motivo – ha sostenuto che le espressioni usate rientrassero nell’alveo della legittima critica politica, fondata su elementi di verità, e che non potessero integrare il delitto di diffamazione.
LA QUESTIONE
Con la pronuncia in esame, il Supremo Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla seguente questione: quali sono i limiti entro cui la critica politica può ritenersi legittima senza sconfinare nel reato di diffamazione.
LA SOLUZIONE
La Suprema Corte, a fronte di un iter argomentativo logico, muove da una preliminare ricognizione dei tratti essenziali della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 595 c.p.
La sentenza ribadisce che, il reato di diffamazione, come noto, tutela l’interesse oggettivo alla reputazione, intesa come rispetto della dignità personale in ambito collettivo e diritto a godere della stima tra i consociati; esige, tra i requisiti distintivi, quello dell’assenza dell’offeso al momento della realizzazione della lesione della reputazione, nel senso che ciò che costituirebbe “ingiuria” al cospetto del suo destinatario integra diffamazione quando alla comunicazione illecita assistano più persone, tra le quali non deve essere presente il soggetto diffamato.
Ciò posto, il Supremo Collegio, ha ritenuto opportuno richiamare alcuni principi giurisprudenziali in tema di delitti contro l’onore, evidenziando che, la causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. invocata dal ricorrente, non può mai travalicare i limiti della verità e della continenza, né può trasformarsi in attacchi gratuiti alla dignità altrui.
Invero, i giudici di legittimità, ribadiscono che costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, anche con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non precipiti in un attacco personale (sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, Alloro, Rv. 28396).
Ne consegue che, in tema di diritto di critica, ciò che determina in primo luogo l’abuso del diritto è la gratuità delle espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione, nonchè l’uso dell’ “argumentum ad hominem”, inteso a screditare l’avversario politico mediante l’’evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni (ex multis, Sez. 5, n. 46132 del 13/06/2014, Rv. 262184; sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Rv. 249239; sez. 5, n. 7990 del 19/05/1998, Rv. 211482).
Sulla scorta di tali principi, appare ictu oculi che le espressioni pronunciate dal ricorrente (“ignorante”, “burattino”, “connivenza mafiosa”) non rappresentino opinioni politiche legittime, bensì affermazioni ingiuriose e infamanti prive di un fondamento fattuale accertato.
Ed anzi, già soltanto l’uso della parola “mafioso”, in assenza della specifica indicazione di un qualsiasi elemento di verità a suo sostegno e senza alcuna giustificazione, trasmoda in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, perchè di contenuto intrinsecamente disonorevole (ex multis, sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016; sez. 5, n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174).
Il Supremo Collegio, invero, ha altresì richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all’esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più contenuto e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (cfr. Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Rv. 249239; Cass., Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, Rv. 270284).
Per tutte le ragioni innanzi esposte, la Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna dell’imputato.
Nota a cura di Alessia Santoro (Avvocato)