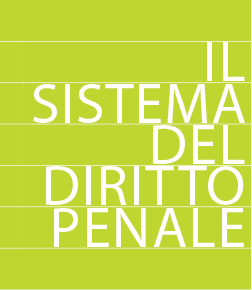La critica sferzante sui social non sempre è diffamazione

Cass. pen., Sez. V, 13 giugno 2025, sentenza n. 22341
LA MASSIMA
“In tema di diffamazione a mezzo social network, la valutazione circa il superamento dei limiti della continenza deve tener conto non solo del linguaggio utilizzato, ma anche delle modalità eccentriche tipiche di tali piattaforme, ferme restando le soglie invalicabili rappresentate dalla gratuita aggressione della sfera personale e dall’esposizione al pubblico disprezzo. Non può ritenersi superato il limite della continenza per il solo utilizzo di espressioni oggettivamente offensive o di cattivo gusto se, alla luce del contesto complessivo, esse risultano funzionali alla finalità di critica, seppur aspramente formulata, e non trasmodano in un’aggressione personale o in un’invettiva umiliante e gratuita”.
IL CASO
La vicenda trae origine da una serie di post pubblicati sul social network Facebook dall’imputata nei confronti di un assessore comunale e della moglie, successivamente costituitisi parte civile nel processo per diffamazione a loro carico. Tra tali post, oggetto specifico del procedimento è stato un commento pubblicato il 3 febbraio 2017, nel quale, utilizzando un linguaggio ironico e volgare, l’imputata aveva messo in dubbio la capacità dell’assessore di attrarre pubblico agli eventi culturali organizzati dallo stesso. In particolare, la frase contestata, sebbene espressa in termini indubbiamente coloriti e sgradevoli, si inseriva in un contesto di aspro dibattito e polemica personale, alimentato da precedenti esternazioni offensive provenienti proprio dalla persona offesa. I giudici di merito avevano ritenuto il contenuto del post lesivo della reputazione, condannando l’imputata alla multa e al risarcimento dei danni nei confronti di entrambi i soggetti offesi. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su più motivi, tra cui l’insussistenza del reato per difetto di procedibilità, il vizio di motivazione in ordine al significato e al contesto delle espressioni incriminate e, soprattutto, la sussistenza dell’esimente del diritto di critica ex art. 51 c.p.
LA QUESTIONE
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un tema particolarmente rilevante e dibattuto nella giurisprudenza e nella dottrina penalistica, ossia l’individuazione del confine tra il legittimo esercizio del diritto di critica e la condotta diffamatoria, con specifico riguardo alle modalità comunicative proprie dei social network. In tale contesto, si poneva la questione se le espressioni utilizzate dall’imputata, pur connotate da volgarità e potenziale offensività, potessero comunque essere ricondotte nell’ambito della lecita critica, in quanto funzionali alla finalità di disapprovazione e inserite in un contesto dialettico e polemico, ovvero se tali espressioni avessero trasceso i limiti della continenza, trasformandosi in un’aggressione gratuita e personale alla reputazione altrui. La problematica, invero, si innesta su un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che riconosce al diritto di critica una tutela ampia, compatibile anche con toni aspri, ironici, provocatori o paradossali, purché non si degeneri nella gratuita e immotivata aggressione della dignità personale o nel pubblico ludibrio. Tuttavia, l’avvento dei social network ha reso più complesso tale bilanciamento, in quanto tali piattaforme amplificano la risonanza delle affermazioni, favoriscono la polarizzazione dei toni e, soprattutto, alterano le tradizionali dinamiche comunicative, rendendo necessario un approccio interpretativo che tenga conto della specificità dei contesti digitali.
LA SOLUZIONE
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato e revocando le statuizioni civili. Nell’adottare tale soluzione, la Quinta sezione ha offerto una ricostruzione sistematica e coerente dei principi che governano il rapporto tra diritto di critica e tutela della reputazione, con particolare attenzione alle peculiarità dei social network.
In primo luogo, la Corte ha ribadito che il diritto di critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 21 cost., può legittimamente estrinsecarsi anche mediante espressioni aspre, severe, ironiche o paradossali, purché finalizzate a rappresentare un giudizio soggettivo di disapprovazione su fatti o comportamenti di rilievo pubblico, senza travalicare i limiti della continenza espressiva. Tale limite, secondo il consolidato insegnamento di legittimità, si sostanzia nell’esigenza che la critica, pur potenzialmente offensiva, sia espressa in forma corretta e funzionale allo scopo di disapprovazione, senza trasmodare in un’aggressione gratuita, immotivata e umiliante della persona.
Nel caso di specie, il Supremo Collegio ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano correttamente applicato tali principi, avendo erroneamente attribuito carattere diffamatorio a un’espressione che, seppur rozza e volgare, risultava chiaramente inserita in un contesto di critica polemica nei confronti dell’attività pubblica della persona offesa. In particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato che il commento incriminato, lungi dall’essere finalizzato a un disprezzo personale o a un’umiliazione gratuita, si limitava ad esprimere, seppur in maniera colorita e poco elegante, un giudizio soggettivo sulla scarsa capacità dell’assessore di attrarre pubblico agli eventi culturali, nell’ambito di un confronto aspro ma circoscritto al piano dell’attività amministrativa e pubblica.
Di rilievo, inoltre, è la valorizzazione da parte della Corte della specificità comunicativa dei social network, che impone di considerare, ai fini della valutazione della continenza, non solo il tenore letterale delle espressioni utilizzate, ma anche le modalità eccentriche e informali proprie di tali piattaforme. In tal senso, la Cassazione ha richiamato un orientamento ormai consolidato (cfr., tra le altre, Cass. pen., Sez. V, n. 8898/2021, Fanini), secondo cui le dinamiche comunicative dei social impongono un’interpretazione meno rigida dei concetti di correttezza formale e di continenza, in quanto tali ambienti virtuali favoriscono l’uso di espressioni colorite, provocatorie o volutamente iperboliche, che, sebbene offensive sul piano letterale, non integrano necessariamente un’aggressione gratuita alla reputazione.
Non può poi trascurarsi il riferimento della Corte all’altro elemento dirimente nella valutazione della continenza, ossia l’assenza di espressioni “ad hominem” umilianti e ingiustificatamente aggressive. Nel caso concreto, infatti, il commento dell’imputata, per quanto volgare e sgradevole, non conteneva espressioni gravemente infamanti o tali da esporre la persona offesa al pubblico disprezzo o al dileggio, ma si limitava a evidenziare un presunto limite professionale nell’ambito di un confronto acceso ma riconducibile al piano della dialettica politica e sociale.
La sentenza si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale che, pur confermando la piena operatività della tutela penale della reputazione anche nei contesti digitali, ribadisce la necessità di un bilanciamento effettivo tra diritto di critica e diritto all’onore, evitando interpretazioni eccessivamente rigorose che finirebbero per comprimere la libertà di espressione, specie nei contesti comunicativi informali e provocatori propri dei social network.
La decisione della Corte offre una lettura equilibrata e attuale dei principi in materia di diffamazione e diritto di critica, riaffermando la centralità della valutazione contestuale e dell’analisi del linguaggio e delle modalità comunicative proprie dei social, nell’ottica di garantire un adeguato bilanciamento tra tutela della reputazione e libertà di manifestazione del pensiero.
Nota a cura di Mariangela Miceli (avvocata)