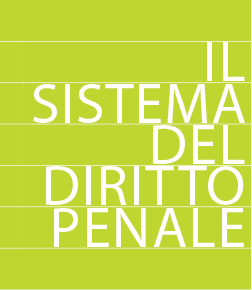La confisca dei beni intestati ad un terzo estraneo al reato

Cass. pen., sez. VI, 10 luglio 2025, sentenza n. 25521
LA MASSIMA
“In materia di confisca ex art. 240-bis c.p., la Corte ribadisce che ai fini dell’operatività dello strumento ablatorio nei confronti del terzo estraneo alla commissione di uno dei reati menzionati da detta norma, grava sull’accusa l’onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino di gravità, precisione e concordanza, l’esistenza della discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, atteso che tale presunzione è prevista dall’art. 240-bis c.p. solo nei confronti dell’imputato. Incombe sull’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l’obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene.”
IL CASO
La controversia trae origine da una pronuncia con cui i giudici di secondo grado avevano rigettato l’opposizione proposta avverso un provvedimento emesso in sede esecutiva, che disponeva – in forza dell’art. 240-bis c.p. – il sequestro finalizzato alla confisca di due immobili. Tali beni risultavano formalmente intestati al figlio di un soggetto condannato con sentenza definitiva per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.
Contro tale decisione l’opponente, ritenendosi leso nei propri diritti patrimoniali, ricorreva per Cassazione, formulando un unico motivo di impugnazione. In particolare, egli denunciava l’inosservanza e la erronea applicazione dell’art. 240-bis c.p., lamentando al contempo gravi carenze motivazionali nel provvedimento impugnato, che appariva viziato sotto il profilo della contraddittorietà e dell’evidente illogicità argomentativa.
LA QUESTIONE
La Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi in merito alla delicata questione dell’individuazione dell’onere probatorio gravante sulla pubblica accusa ai fini dell’applicazione della misura ablatoria prevista dall’art. 240-bis c.p., quando essa venga disposta nei confronti di un soggetto terzo, formalmente estraneo alla commissione dei reati presupposto contemplati dalla medesima disposizione.
La questione al vaglio dei giudici di legittimità è infatti incentrata sul delicato bilanciamento tra l’efficacia repressiva dell’istituto della confisca e la tutela dei diritti dei soggetti non coinvolti penalmente. Se, da un lato, la confisca rappresenta uno strumento essenziale per contrastare l’arricchimento illecito e privare il reo dei beni frutto o mezzo del reato, dall’altro essa non può estendersi automaticamente a beni formalmente intestati a soggetti diversi dall’imputato, se non in presenza di specifici presupposti.
Mentre l’imputato, infatti, in quanto soggetto su cui grava l’accusa penale, può essere direttamente destinatario di misure ablatorie in ragione del nesso tra il reato ed i beni da confiscare (sulla base anche di una semplice presunzione dell’illecito arricchimento), per il terzo, la l’ablazione è consentita solo a fronte della dimostrazione di un suo coinvolgimento diretto, o quantomeno di una effettiva consapevolezza del rischio legato alla commissione del reato. Il tutto sempre alla luce di una accurata valutazione della proporzionalità della misura da applicare.
La giurisprudenza costituzionale, di legittimità e sovranazionale è stata attenta nell’elaborare una rete di garanzie volta ad evitare che strumenti nati per colpire l’illegalità si traducano in indebite compressioni dei diritti fondamentali (in primis il diritto di proprietà) di soggetti estranei al reato.
In tale prospettiva, il principio di personalità della responsabilità penale, assieme alla tutela della buona fede e del diritto di difesa del terzo, costituiscono un presidio imprescindibile per l’interprete, chiamato ad operare un costante bilanciamento tra esigenze di prevenzione e repressione e salvaguardia dei diritti fondamentali.
LA SOLUZIONE
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le doglianze sollevate dal ricorrente. Tra le motivazioni che hanno condotto il Supremo Collegio a tale conclusione, assume particolare rilievo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, per procedere alla confisca ex art. 240-bis c.p. nei confronti di un soggetto terzo estraneo alla commissione dei reati presupposto, è necessario che il pubblico ministero fornisca una prova specifica e concreta. Tale prova deve fondarsi su elementi fattuali gravi, precisi e concordanti che dimostrino l’esistenza di una divergenza sostanziale tra la titolarità formale del bene e la sua reale disponibilità. Non è sufficiente, ai fini della confisca, fare leva su una mera presunzione di sproporzione tra il valore dei beni intestati al terzo e il reddito da questi dichiarato, poiché tale presunzione opera esclusivamente nei confronti dell’imputato, come espressamente previsto dalla norma (cfr. Cass., Sez. II, 15 giugno 2023, n. 37880).
Pertanto, grava sull’accusa l’onere di dimostrare in modo rigoroso che l’intestazione del bene al terzo sia meramente apparente e sia stata realizzata con lo scopo di eludere l’applicazione della confisca, mantenendo il bene nella disponibilità effettiva del condannato. In questo quadro, il terzo deve risultare consapevolmente coinvolto in un meccanismo di interposizione fittizia, funzionale alla sottrazione del bene all’autorità giudiziaria.
Allo stesso tempo, stabilisce la Corte, il giudice ha il dovere di motivare puntualmente la propria decisione, illustrando le ragioni che lo hanno condotto a ritenere simulata l’intestazione e richiamando non solo indizi sintomatici di rilievo, ma anche fatti concreti dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, tali da integrare una prova logica e indiretta della non coincidenza tra titolarità formale e disponibilità effettiva (cfr. Cass., Sez. V, 6 marzo 2017, n. 13084).
Questa ricostruzione garantisce una duplice forma di tutela per il terzo, impedendo che egli venga coinvolto – in assenza di un’adeguata base probatoria – in procedimenti penali relativi a condotte del tutto estranee alla sua sfera personale e giuridica.
Nota a cura di Maria Teresa Beninato