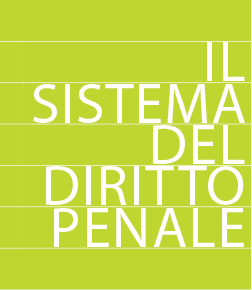La coartazione della libertà e dell’autonomia negoziale integra il reto di estorsione contrattuale

Cass., II Sez., 9 luglio 2025, sentenza n. 25415
LA MASSIMA
“Nel delitto di estorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l’agente o con altri soggetti, l’elemento dell’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno”.
IL CASO
Il Tribunale del riesame confermava l’ordinanza del G.I.P. di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere, in relazione al delitto di tentata estorsione contestato al ricorrente, quale esponente della società appaltatrice, ai danni della società committente. In particolare, si rimproverava all’indagato di aver minacciato di morte e di gravi ritorsioni, in concorso con altri tre soggetti e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, due dipendenti della società committente, per costringere quest’ultima a non recedere dal contratto di facchinaggio con l’azienda appaltatrice o, almeno, a riconoscere una compensazione economica di “buona uscita”.
I correi, infatti, avrebbero tentato di imporre alle persone offese la prosecuzione di rapporti economici nel ramo delle spedizioni, avvalendosi del potere di intimidazione dato dalla vicinanza a una famiglia mafiosa del territorio.
Avverso l’ordinanza del riesame, la difesa dell’imputato ricorreva in Cassazione.
In primo luogo, si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla inidoneità degli atti e dell’elemento soggettivo della tentata estorsione, poiché dal modus agendi adottato non si sarebbero rilevati gli elementi richiesti né per la configurazione del reato in oggetto né per il conseguimento dell’ingiusto profitto con altrui danno. Al più, a parere della difesa, la condotta avrebbe potuto essere inscritta nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone o in quella di violenza privata.
In secondo luogo, si censurava la violazione di legge e il vizio di motivazione sull’impiego del metodo mafioso, quale circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 1, c.p. Infatti, il Tribunale avrebbe affermato la “responsabilità da posizione” del ricorrente sulla base del presunto coinvolgimento della società appaltatrice allo stesso riconducibile nell’organizzazione criminale, per via dei legami familiari degli indagati con un soggetto già detenuto e condannato per reati associativi. Tuttavia, dalle intercettazioni di lunga durata non sarebbe emerso alcun contatto con i clan mafiosi.
LA QUESTIONE
La decisione della Corte impone di focalizzarsi sui tratti caratterizzanti il delitto di estorsione di cui all’art. 629 c.p., così da coglierne la portata nel caso concreto.
La norma incrimina la condotta di chi, mediante violenza o minaccia, coarti la volontà della vittima costringendola a tenere determinati comportamenti, attivi od omissivi, forieri di un duplice effetto: l’uno consistente nell’ingiusto vantaggio dell’autore, l’altro nel danno per la vittima.
Si tratta, dunque, di una fattispecie plurioffensiva, risultando lesi sia il patrimonio che la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. La dottrina precisa, poi, che tale reato si realizza con la cooperazione artificiosa della vittima, atteso che l’atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole, pur se dovuto alla condotta violenta o minacciosa dell’agente, è realizzato dalla parte offesa in modo cosciente e volontario.
Quanto al comportamento minaccioso, si precisa che la minaccia consiste nella prospettazione di un male futuro, la cui verificazione dipende dalla volontà dell’autore.
La stessa, però, deve essere connotata da serietà e idoneità a incidere sulla volontà del minacciato: sebbene possa assumere forme molteplici – esplicita o tacita, determinata o indiretta – essa, però, deve essere finalizzata all’ottenimento di un profitto ingiusto con altrui danno. Nell’estorsione contrattuale, inoltre, la minaccia comporta il recesso da rapporti negoziali in caso di mancata adesione dell’altro contraente alle pretese della controparte, allo scopo di coartare l’esecuzione di prestazioni non dovute nell’an e nel quantum. L’illiceità della minaccia si ravvisa nel conseguimento di un profitto ingiusto quale risultato iniquo, perché ampiamente esorbitante ovvero non dovuto rispetto a quello perseguibile attraverso l’esercizio corretto del diritto.
Nello specifico, il profitto si reputa ingiusto quando è contra ius, ossia contrario alla legge, o non iure, cioè quando l’utilità che l’agente si propone di realizzare con l’azione criminosa non è dovuta per legge. Inoltre, per stabilire se il profitto sia ingiusto, occorre verificare il rapporto tra il mezzo coattivo usato e il vantaggio patrimoniale avuto di mira.
Pertanto, se il mezzo utilizzato è di per sé antigiuridico, il profitto si presume ingiusto integrandosi il delitto di estorsione; al contrario, se il male minacciato non è di per sé antigiuridico, occorre stabilire se tali mezzi siano stati utilizzati per perseguire i fini per i quali la legge li appresta oppure no.
È, poi, necessario valutare se la pretesa avanzata sia riconosciuta e tutelata dall’ordinamento. Nell’estorsione, infatti, l’agente persegue l’ottenimento del profitto pur nella consapevolezza di non averne diritto: l’elemento intenzionale è dato dalla coscienza dell’illegittimità di quanto preteso. Diversamente, nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’art. 393 c.p. si esercita un preteso diritto azionabile: rileva la convinzione ragionevole, anche se giuridicamente infondata, di attuare un preciso diritto e di realizzare personalmente e direttamente una pretesa che potrebbe obiettivamente formare oggetto di una vertenza giudiziaria. Quanto al rapporto tra estorsione e violenza privata di cui all’art. 610 c.p., si sottolinea che il soggetto passivo della fattispecie estorsiva deve conservare un certo margine, per quanto esiguo, di autonomia per scegliere di sottrarsi al male, facendo od omettendo qualche cosa. Nella formulazione della norma sulla violenza privata, invece, il legislatore ha utilizzato termini molto generici, al fine di coprire un ampio novero di comportamenti: non solo atti positivi come il “dare” o il “facere” in senso stretto, ma anche atti negativi di “non facere” o mere tolleranze tali, però, da incidere, in modo diretto o indiretto, sul patrimonio della vittima. Infine, si configura l’aggravante del metodo mafioso quando siano accertate un’attività intimidatoria connotata da “mafiosità” e la realizzazione di condotte che siano riconducibili agli interessi del clan mafioso che ha il controllo sul relativo territorio o che siano rese possibili con l’ausilio degli appartenenti al sodalizio.
LA SOLUZIONE
Per la seconda Sezione della Corte di Cassazione il ricorso dell’imputato è infondato ed è dichiarato dalla stessa inammissibile.
Secondo i giudici di legittimità, nessun dubbio residua sul fatto che attraverso la costrizione il ricorrente e i coindagati abbiano agito al fine di conseguire un ingiusto profitto di carattere patrimoniale. Perde, inoltre, ogni rilevanza l’ulteriore questione relativa al fatto che i correi abbiano agito anche per ottenere la consegna di una somma di denaro come risarcimento per l’avvenuta risoluzione del contratto, circostanza che, secondo la difesa, sarebbe stata ricollegata alla violazione dell’obbligo di correttezza nelle trattative precontrattuali. Né può riqualificarsi il delitto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’art. 393 c.p., dal momento che, a parere della Corte, non è stato dimostrato che la società fosse titolare di un diritto giudiziariamente azionabile al rinnovo del contratto di appalto alla sua scadenza. Allo stesso modo, la Cassazione esclude l’inquadramento nella violenza privata, ritenendo che il delitto di estorsione costituisca ipotesi speciale rispetto al delitto di violenza privata, fungendo da elementi specializzanti, oltre al conseguimento di un ingiusto profitto, il correlativo danno per la persona offesa.
Da ultimo, è infondata anche la dedotta insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 1, c.p. infatti, le frasi con cui sono state prospettate ritorsioni colpendo i singoli corrieri privati con la sparizione di mezzi o l’eventuale incendio degli stessi, nonché le pesanti minacce all’incolumità nelle persone offese con richiami alla famiglia di appartenenza dei soggetti agenti, sono esplicative di modalità della condotta che evocano la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso.
Segnalazione a cura di Vincenza Urbano