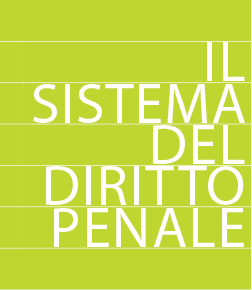Il delitto di invasione di terreni: configurabilità e regime sanzionatorio.

Cass. pen., Sez. II, 17 giugno 2025, sentenza n. 22653
LE MASSIME
«Non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui (nella specie demaniale) per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente».
«Non può configurarsi la continuazione nel possesso abusivo iniziato da altri, quando la condotta del successore non si limiti a ricevere passivamente il bene nello stato di fatto lasciato dal dante causa, ma si attivi mediante la realizzazione di opere che producono un ulteriore rafforzamento, consolidamento e ampliamento della situazione di fatto, così da distinguersi come una condotta – configurante il delitto di cui all’art. 633 c.p. – autonoma e ulteriore rispetto a quella realizzata dall’originario possessore».
«In presenza di un reato permanente, in caso di successione di leggi, deve applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto al momento della cessazione della permanenza».
IL CASO
Con sentenza del 19 settembre 2024 la Corte di Appello confermava la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato l’imputato per il reato di invasione di terreni o edifici -aggravato dalla circostanza che l’area oggetto dell’occupazione appartenesse al demanio – e aveva dichiarato di non doversi procedere per il reato di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso, estinto per prescrizione.
Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione e deduceva: a) la mancata riqualificazione dei fatti da parte dei giudici di primo grado, i quali, rilevato che i manufatti erano stati realizzati dal padre dell’imputato, avrebbero dovuto riqualificare la condotta del ricorrente in quella di ristrutturazione; b) il travisamento dei fatti, dal momento che, sebbene il ricorrente, assegnatario dell’abitazione, fosse stato indicato quale autore dell’originaria occupazione e illegittimo possessore, dall’istruttoria era emerso che l’occupazione era stata realizzata dal padre, con conseguente insussistenza del dolo richiesto per la fattispecie; c) la violazione dell’art. 2 c.p. per essere stata applicata la pena prevista al momento della pronuncia della sentenza e non quella vigente all’epoca dei fatti.
LA QUESTIONE
Nella sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione – chiamata a pronunciarsi in ordine alla riconducibilità dei fatti in capo al ricorrente -, ha delineato la differenza tra la condotta di chi, limitandosi a ricevere passivamente il bene nello stato di fatto lasciato dal dante causa, continui ad esercitare un possesso abusivo iniziato da altri e chi, invece, attivandosi per la realizzazione di opere che producono un ulteriore rafforzamento, consolidamento e ampliamento della situazione di fatto, integri con la propria condotta il delitto di cui all’art. 633 c.p.
LA SOLUZIONE
Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso fondato in relazione al trattamento sanzionatorio e infondato con riferimento agli altri motivi.
Invero, secondo la Corte di Cassazione, i giudici di secondo grado hanno correttamente escluso che, nel caso in esame, vi fosse stata una continuazione nel possesso dei manufatti che rappresentavano la concretizzazione di un’occupazione iniziata da altri.
In particolare, dall’istruttoria era emerso che l’imputato aveva sistemato e rifinito una baracca costituita da lamiere e originariamente installata dal padre, utilizzandola anche come ricovero per gli animali. In tal modo, il ricorrente non si era limitato a ricevere passivamente il bene nello stato di fatto in cui lo aveva lasciato il padre, continuando a possedere illegittimamente l’area, bensì aveva contribuito attivamente alla realizzazione di opere che avevano prodotto un ampliamento e un rafforzamento della struttura, apponendo altresì un recinto ed escludendo gli altri condomini dal godimento di un terreno di pertinenza del complesso di abitazioni appartenenti al demanio.
Per tale ragione, è stata esclusa l’applicazione al caso in esame del principio di diritto secondo cui «non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui (nella specie demaniale) per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente».
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il ricorrente aveva posto in essere una condotta autonoma e ulteriore rispetto a quella realizzata dal padre, integrando il delitto di cui all’art. 633 c.p., tanto sul piano dell’elemento oggettivo quanto sotto il profilo dell’elemento psicologico.
Con riferimento, invece, al regime sanzionatorio applicato la Corte di Appello aveva osservato che la permanenza del reato era cessata alla data di emissione della sentenza di primo grado (il 27 novembre 2023), quando era già entrata in vigore la riforma normativa che aveva aggravato il trattamento sanzionatorio del delitto di cui all’art. 633 c.p. sostituendo alla pena detentiva alternativa alla pena pecuniaria, la pena detentiva congiunta a quella pecuniaria. Per tale ragione, la Corte di Appello aveva determinato la pena applicando la nuova disciplina sanzionatoria, sulla base del consolidato principio secondo cui, in presenza di un reato permanente, nell’ipotesi di successione di leggi, deve applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto al momento della cessazione della permanenza.
Tuttavia, in ipotesi di contestazione “chiusa”, cioè quando la durata della condotta è temporalmente delimitata nel capo di imputazione, come nel caso in esame, la pena da infliggere avrebbe dovuto essere determinata sulla base della disciplina più favorevole, dal momento che il principio condiviso dai giudici di merito trova applicazione soltanto quando manca la specificazione del termine finale della condotta (c.d. contestazione “aperta”).
Nota a cura di Laura Maria Pullara