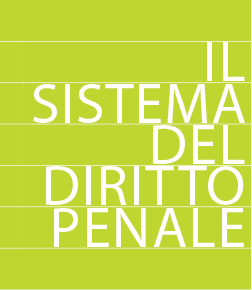È riciclaggio la nazionalizzazione di un veicolo mediante documenti contraffatti

Cass. pen., Sez. II, 9 luglio 2025, sentenza n. 25360
LA MASSIMA
“Dal punto vista materiale va ricondotta nell’alveo del riciclaggio e non in quello della ricettazione o dell’incauto acquisto, la pratica della nazionalizzazione del veicolo avvalendosi di documenti tedeschi contraffatti, in quanto sia condotta strumentale eziologicamente necessaria a creare il “clone” e a consentirne l’offerta in vendita, quanto idonea ad ostacolarne l’individuazione della provenienza delittuosa”.
IL CASO
La vicenda trae origine dalla pronuncia di primo grado, poi confermata in Appello, con la quale gli imputati, in concorso tra loro, venivano condannati alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 112 e 648-bis c.p., per aver immesso sul mercato, al fine di rivenderla, un’auto di provenienza furtiva resa “clone” di altra automobile dello stesso tipo circolante in Germania – apparentemente nazionalizzata mediante utilizzo di documenti tedeschi contraffatti – mai importata in Italia.
Avverso la decisione di merito, le difese degli imputati hanno esperito ricorso per cassazione fondando le proprie argomentazioni su una pluralità di motivi tra i quali: l’assenza di prova della manomissione dell’auto; la presenza di una mera intestazione del veicolo per mera cortesia nei confronti della coimputata, suocera della figlia; l’irrilevanza della condotta di c.d. nazionalizzazione dell’autovettura ai fini della configurabilità della fattispecie ascritta.
In sintesi, è stata censurata la mancanza di un’adeguata motivazione in ordine alla ricorrenza degli elementi oggettivi e soggettiva dell’ipotesi di riciclaggio, nonché alla prova di un accordo criminoso dei correi a commettere tale delitto.
LA QUESTIONE
Con la pronuncia in commento, la Cassazione si è pronunciata circa la corretta cornice ermeneutica e gli elementi costitutivi del reato di riciclaggio – con particolare riguardo alle ipotesi aventi ad oggetto veicoli – anche alla luce della connessa evoluzione giurisprudenziale. La Corte si è altresì soffermata sul concorso di persone nel reato richiamandone la concezione unitaria.
LA SOLUZIONE
Nel fornire una disamina esaustiva delle questioni di diritto rimessele, la Corte ha ripercorso, in primis, gli arresti giurisprudenziali consolidatisi in materia.
Più nel dettaglio, ribadita la natura di reato a forma libera del riciclaggio – la Corte ha precisato che il comportamento costitutivo del delitto può comprendere una serie di atti distinti, anche legali di per sé, svolti in momenti diversi, purché collegati in modo unitario all’obiettivo comune di occultare l’origine illecita del denaro, dei beni o di altre utilità; di talché, il tipo criminoso sarà integrato con il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell’aggirare la libera e normale esecuzione dell’attività posta in essere (così, a recente conferma, Cass. pen., Sez. II, 05 marzo 2024, sentenza n. 10927, Cass. pen., Sez. II, 16 novembre 2012, sentenza n. 3397).
La Seconda Sezione ha poi ripercorso il formante giurisprudenziale in materia nei casi in cui l’oggetto della fattispecie s’identifichi in un veicolo. In tali ipotesi, saranno connotate dei requisiti di tipicità le operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione del bene, così da impedire il collegamento con il proprietario che ne è stato spogliato. In ciò, a ben vedere, si rinvengono i tratti distintivi dalla contigua ipotesi di ricettazione (cfr., tra le altre, Cass. pen., Sez. II, 15 giugno 2011, sentenza n. 35439, secondo la quale integra riciclaggio già lo smontaggio del veicolo “con separazione fisica tra il veicolo inteso nella sua completezza funzionale ed alcuni pezzi dello stesso (in particolare la targa) indubbiamente idonei ad identificarne la provenienza”).
Il delitto di cui all’art. 648-bis c.p. troverà spazio applicativo, altresì, ogniqualvolta la condotta del reo si sostanzi nell’asportazione dei dati identificativi del veicolo, quali, oltre alla targa, il numero di telaio e la targhetta identificativa del veicolo, con apposizione del telaio di altro veicolo e collocazione di altra targa rispetto a quella originaria (cfr. Cass. pen., Sez. II, 11 gennaio 2019, sentenza n. 8788). Parimenti, sarà sussumibile nella fattispecie codicistica, in luogo della violazione amministrativa di cui all’art. 97 c.d.s., la condotta del soggetto che, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa per il quale è necessaria, ai fini della legittima circolazione, la dotazione di una targa, vi apponga una targa di sua proprietà, appartenente a diverso veicolo, in quanto attraverso tale condotta si produce l’effetto di ostacolo all’identificazione della provenienza del bene, che la norma intende sanzionare.
Declinando tali principi nel caso in esame, la Corte ha concluso nel senso che va ricondotta nell’alveo del riciclaggio e non in quello della ricettazione o dell’incauto acquisto, la pratica della nazionalizzazione del veicolo avvalendosi di documenti tedeschi contraffatti, in quanto condotta strumentale eziologicamente necessaria a creare il “clone” e a consentirne l’offerta in vendita, quanto idonea ad ostacolarne l’individuazione della provenienza delittuosa.
La statuizione di diritto, a giudizio del consesso, trova conforto nella circostanza per cui la condotta di parte non si è esaurita nella mera ricezione del bene, ma presentava un quid pluris, costituito di un’attività materiale causalmente idonea, da un lato, a consentire la circolazione e, dunque, la sua rimessione sul mercato, dall’altra, ad assumere valenza causale ai fini della successiva truffa, atteggiandosi quale antecedente necessario per rendere la res oggetto di negozi giuridici asseverando l’apparenza della sua provenienza lecita.
Intervenendo, poi, sull’altro motivo di censura- concernente la prova di un pactum sceleris a commettere il delitto contestato – la pronuncia in rassegna muove dalla concezione unitaria del concorso di più persone nel reato, recepita nell’art. 110 cod. pen., a tenore della quale l’attività costitutiva della partecipazione può essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico idoneo ad offrire un contributo apprezzabile alla commissione del reato, la cui prova può essere fornita anche in via logica o indiziaria, mediante elementi dotati di sicura attitudine rappresentativa che involgano sia il rapporto di causalità materiale tra condotta e evento che il sostrato psicologico dell’azione.
Nel caso di specie, proprio la valorizzazione degli elementi fattuali emersi e la partecipazione degli imputati ai momenti significativi della filiera illecita – quali l’assenza di una spiegazione in merito alla provenienza del veicolo, il contributo offerto nella nazionalizzazione del clone, il ruolo ricoperto nella vendita e la partecipazione alla successiva spartizione del provento– ha permesso di recuperare una lettura di quei contatti e di quelle relazioni nell’ambito di un ordito concorsuale in cui ogni compartecipe ha svolto la sua parte.
Alla luce del percorso ermeneutico tracciato, la sentenza si conclude con una statuizione in termini di inammissibilità dei ricorsi presentati dagli imputati in quanto prospettanti delle letture alternative di merito in aperto ed inconciliabile contrasto con la coerente e logica ricostruzione dei fatti formulata dai giudici di merito.
Segnalazione a cura di Andrea Bonanno