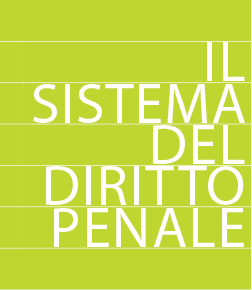Diritto di critica e verità putativa

Cass. Pen, Sez. V del 27 agosto 2025, n. 29859
LA MASSIMA
Il diritto di critica — quale manifestazione della libertà di pensiero garantita dall’art. 21 Cost. — può assumere efficacia scriminante quando sia esercitato nel rispetto dei limiti della verità (anche putativa), della continenza espressiva e della pertinenza rispetto a un interesse pubblico o socialmente rilevante. In particolare, è stato chiarito che l’esimente putativa dell’art. 51 c.p. è configurabile anche in assenza di una verità processualmente accertata, qualora il soggetto agente operi nella ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti oggetto di censura, purché tale convinzione sia fondata su elementi oggettivi e non frutto di arbitraria supposizione.
IL CASO
In seguito alla condanna per il reato di cui all’art. 595 comma terzo c.p., per avere inviato al Sindaco e ad altri enti pubblici, nonché ai cittadini del Comune, due lettere ed una e-mail con le quali accusava il Sindaco e l’amministrazione comunale di sistematiche violazioni di norme, irregolarità e comportamenti omissivi e reticenti, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al diritto di critica. La sentenza impugnata ha infatti escluso la configurabilità della scriminante di cui all’art. 51 c.p., in quanto la Corte territoriale, a parere della difesa, ha omesso di valutare il requisito della verità putativa che sussiste allorquando l’accusatore sia fermamente convinto della veridicità dei fatti che afferma.
LA QUESTIONE
La Corte di Cassazione, nella pronuncia in esame, si sofferma sulla configurabilità della scriminante dell’esercizio del diritto di critica, anche nella sua forma putativa, ai sensi dell’art. 51 c.p.
In particolare, la questione sottoposta alla Suprema Corte concerne il riconoscimento della c.d. verità putativa, che si configura quando l’autore della critica opera nella convinzione ragionevole e giustificabile della veridicità dei fatti, basandosi su elementi oggettivi e non su mere supposizioni.
LA SOLUZIONE
La scriminante dell’esercizio di un diritto ex art 51 c.p., espressione del principio di non punibilità per chi agisca in conformità ad un diritto riconosciuto dall’ordinamento, costituisce una causa di giustificazione che opera quando la condotta dell’agente si collochi nell’ambito di un diritto soggettivo, purché esercitato nei limiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge. In dottrina, si è evidenziato come l’art. 51 c.p. rappresenti una clausola generale di liceità, che consente di escludere l’antigiuridicità del fatto quando esso sia espressione di un diritto sostanziale, anche se esercitato in forma putativa, purché l’errore sia scusabile.
La giurisprudenza di legittimità ha individuato i presupposti di operatività della causa di giustificazione in esame ed ha costantemente affermato che il diritto di critica — quale manifestazione della libertà di pensiero garantita dall’art. 21 Cost. — può assumere efficacia scriminante quando sia esercitato nel rispetto dei limiti della verità (anche putativa), della continenza espressiva e della pertinenza rispetto a un interesse pubblico o socialmente rilevante.
In particolare, è stato chiarito che l’esimente putativa dell’art. 51 c.p. è configurabile anche in assenza di una verità processualmente accertata, qualora il soggetto agente operi nella ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti oggetto di censura, purché tale convinzione sia fondata su elementi oggettivi e non sia frutto di arbitraria supposizione.
Ai fini dell’efficacia scriminante, è altresì necessario che la critica non si traduca in un attacco personale, ma si mantenga entro i limiti della continenza, e che il fatto oggetto di censura sia obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali, ovvero ritenuto tale per errore scusabile.
Nel caso di specie, ad avviso della Corte di legittimità, le comunicazioni inviate dall’imputato, mediante lettere ed e-mail indirizzate a diverse autorità pubbliche, risultano articolate, circostanziate e corredate da documentazione allegata.
Inoltre, si osserva che le espressioni ritenute diffamatorie non appaiono gratuite bensì necessarie e funzionali alla costruzione del giudizio critico, inserendosi in un contesto di legittima sollecitazione istituzionale, finalizzata alla rappresentazione di presunte irregolarità amministrative e alla richiesta di chiarimenti da parte della pubblica amministrazione, che non aveva fornito riscontro.
In tale contesto, riconducibile a una legittima sollecitazione istituzionale, l’imputato, dopo aver ripercorso l’attività di alcuni consiglieri comunali e richiamato le osservazioni critiche espresse dal consulente del Comune, ha ribadito le irregolarità da lui ritenute sussistenti, chiedendo al Sindaco una risposta che confuti le affermazioni ritenute infondate con preciso riferimento ai fatti, ai documenti e alle norme cui gli amministratori dichiarano di volersi attenere.
A ciò si aggiunge il contributo dichiarativo di un consigliere di minoranza, il quale ha riferito che il proprio gruppo consiliare si era fatto carico di portare all’attenzione del consiglio comunale la questione concernente presunti abusi e omissioni da parte dell’amministrazione comunale.
Pertanto, ad avviso della Corte di cassazione, le modalità con cui l’imputato ha manifestato le proprie doglianze, unitamente al contenuto delle dichiarazioni testimoniali, impongono un ulteriore approfondimento da parte del giudice di merito, volto a verificare la sussistenza della scriminante di cui all’art. 51 c.p., anche nella sua forma putativa, non essendo stata fornita alcuna motivazione sul punto da parte della Corte territoriale.
Nota a cura di Giulia Boursier Niutta