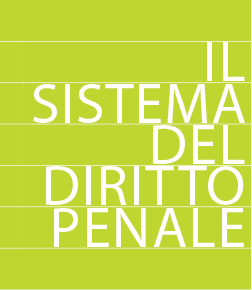Bancarotta per distrazione da parte del socio amministratore che vanti crediti per il lavoro prestato nell’interesse della società

Cass. pen., Sez. V, 3 luglio 2025, sentenza n. 24586
LA MASSIMA
“Configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società, senza l’indicazione di elementi che ne consentano un’adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, segnatamente di persone, non è assimilabile né ad un contratto d’opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l’eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l’accertamento dell’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all’immedesimazione organica”.
IL CASO
Con la pronuncia in esame, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso di uno degli imputati avverso la sentenza con cui la Corte d’appello territoriale aveva parzialmente riformato la decisione dei giudici di primo grado che, con riferimento al fallimento di una società in nome collettivo, aveva riconosciuto i soci illimitatamente responsabili per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale. I giudici d’appello avevano riqualificato le condotte originariamente contestate come bancarotta fraudolenta documentale e, unificate le due condotte a fini sanzionatori in un unico delitto, altresì in quello di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell’art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall., avevano condannato gli imputati alle pene ritenute di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare, costituitasi parte civile.
La condotta contestata agli imputati riguardava prelevamenti di denaro, effettuati dalle casse sociali, originariamente contabilizzati come crediti vantati dalla società nei confronti dei soci, stornati nel successivo bilancio d’esercizio e inseriti come posta di patrimonio passivo netto, senza che le somme fossero state mai realmente restituite alla società. Mediante questa riqualificazione il patrimonio si riteneva avesse assunto un valore negativo, con conseguente “rinuncia” della società ad ottenere la restituzione delle somme.
Uno degli imputati ha dunque proposto ricorso in Cassazione. Il ricorrente ha lamentato, anzitutto, l’insussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sul presupposto che sebbene socio illimitatamente responsabile, egli fosse un mero dipendente della società, con compiti di manovale, privo delle competenze tecniche necessarie per avvedersi di irregolarità contabili e gestionali, pertanto convinto di aver riscosso la sua retribuzione e non un credito della società fallita verso i soci.
Ribadendo di aver sempre ritenuto che le somme prelevate fossero a titolo di retribuzione per l’attività prestata in favore della società, con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sostenendo di non aver commesso il fatto; infine, ha denunciato vizi di motivazione in ordine al suo effettivo ruolo all’interno della società. Egli, sebbene socio illimitatamente responsabile, nella sostanza aveva sempre svolto l’attività di manovale, incaricato di organizzare le maestranze di lavoro tra i vari cantieri e privo di poteri gestionali; il suo stipendio era stabilito dai reali amministratori della società ed egli si limitava a ricevere e incassare il relativo assegno.
Quanto premesso era stato riconosciuto dalla Corte territoriale che aveva prosciolto gli altri due imputati dal delitto di bancarotta semplice documentale, ritenendo unico responsabile del fatto il socio cui era stata affidata la tenuta delle scritture contabili.
LA QUESTIONE
La questione al vaglio della Suprema Corte è incentrata sulla condotta distrattiva che integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale; in particolare, occorre chiarire la corretta qualificazione dei prelevamenti effettuati dal socio amministratore di una società di persone, che incassa dalle casse sociali somme corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società.
LA SOLUZIONE
Relativamente all’attività svolta di fatto dal socio, la Corte ha correttamente ritenuto come non si possa sostenere giuridicamente che egli si sia limitato a percepire il proprio stipendio come un qualsiasi lavoratore dipendente della società stante il rapporto di immedesimazione organica che lega il socio illimitatamente responsabile alla società di persone e pertanto non assimilabile ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. Talché la Corte ha richiamato un proprio principio di diritto secondo cui “configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società, senza l’indicazione di elementi che ne consentano un’adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, segnatamente di persone (oltreché di capitali, alla luce di Sez. Un. Civ. n. 1545 del 2017, Rv. 642004-03), non è assimilabile né ad un contratto d’opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l’eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l’accertamento dell’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all’immedesimazione organica”.
In secondo luogo, e in relazione alla qualificazione degli spostamenti delle poste patrimoniali, la Suprema Corte ha evidenziato che la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale nel caso di specie non sia stata realizzata attraverso la diversa apposizione contabile, bensì mediante i prelevamenti di somme di denaro e che non trovavano giustificazione in alcun credito di pari importo nei confronti del soggetto ricorrente, né a titolo di distribuzione di utili o fattispecie similari, trattandosi di fatto di espedienti contabili che dissimulavano le condotte distrattive già attuate in precedenza dalla compagine amministrativa.
Nota a cura di Matteo Castiglione