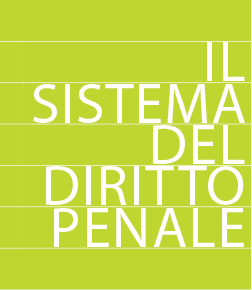Disturbi della personalità e vizio totale o parziale di mente

Cass. pen. Sez. I, 27 agosto 2025, sentenza n. 29849
LA MASSIMA
“Ai fini del riconoscimento del vizio totale e parziale di mente, se è vero che anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità, è del pari certo che tale approdo può dirsi soltanto quando essi siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola grandemente scemare, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato si configuri causalmente determinato dal disturbo mentale. Di conseguenza, non può ammettersi rilievo, ai fini dell’imputabilità, ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, al pari degli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio d’infermità.”
IL CASO
La vicenda portata all’attenzione del Supremo Consesso trae origine dal ricorso presentato dall’imputato, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di secondo grado. In particolare, i giudici d’appello avevano confermato la decisione resa in primo grado, riconoscendo l’imputato responsabile del reato di omicidio aggravato in danno della convivente e della madre di quest’ultima.
Avverso tale pronuncia, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, tra i motivi, sia l’omessa considerazione del vizio parziale di mente sia l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 577, comma 1, n. 1 c.p., relativa alla stabile convivenza con la persona offesa.
LA QUESTIONE
Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su due questioni giuridiche.
La prima concerne la possibilità di ricomprendere i disturbi della personalità nel concetto infermità mentale, rilevante ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente e, dunque, dell’imputabilità dell’agente.
La seconda riguarda, invece, la corretta interpretazione dell’aggravante prevista per l’omicidio commesso nei confronti della persona stabilmente convivente (art. 577, comma 1, n. 1, c.p.) e, conseguentemente, la sua corretta contestazione in sede processuale.
LA SOLUZIONE
La Suprema Corte, in linea con un orientamento ormai consolidato, ha stabilito che, anche i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità mentale, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente. Tuttavia, ciò è possibile solo al ricorrere di specifiche condizioni: i disturbi della personalità devono presentare una consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, fino a escluderla o comprometterla significativamente. È, inoltre, essenziale che sussista un nesso causale tra il disturbo e la condotta criminosa, tale da rendere la patologia psichica causalmente determinante nella commissione del reato.
Ne consegue che, ai fini dell’imputabilità, non assumono rilevanza le anomalie caratteriali, le alterazioni o le disarmonie della personalità che non presentino le suddette caratteristiche di gravità e incidenza sulla sfera volitiva o intellettiva del soggetto. Lo stesso principio si applica per gli stati emotivi e passionali, i quali possono rilevare solo se inseriti in un più ampio quadro di effettiva infermità mentale.
Chiarito ciò, la Corte di Cassazione passa ad esaminare la seconda questione, relativa all’aggravante di cui all’art. 577, comma 1, n.1 c.p. In particolare, i giudici di legittimità chiariscono che il concetto di “relazione affettiva” non deve essere confuso con quello di “stabile convivenza”. Invero, l’aggravante della stabile convivenza non è configurabile nei casi di coabitazione temporanea, ma presuppone – anche a seguito dell’interruzione del legame affettivo – che la vittima e l’aggressore abbiano condiviso, per un periodo di tempo significativo, abitudini di vita e continuino a condividere spazi comuni. Tale interpretazione trova fondamento, in primo luogo, nel dato letterale della norma: il legislatore, intervenendo sulla disposizione, ha sostituito la congiunzione “e” con la disgiuntiva “o”, attribuendo così valore autonomo alla stabile convivenza, intesa come situazione di fatto distinta dal legame affettivo esistente tra le persone coinvolte. L’intento della norma è, dunque, quello di offrire una maggiore tutela alla parte più debole, in un momento di particolare vulnerabilità. Questo obiettivo risulta ulteriormente confermato, sul piano logico e sistematico, dalla differente valutazione del disvalore penale attribuito all’omicidio commesso nei confronti della persona “già stabilmente convivente”, anche qualora la convivenza sia cessata.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso avanzato dal ricorrente e lo condanna al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civile.
Nota a cura di Angela De Girolamo