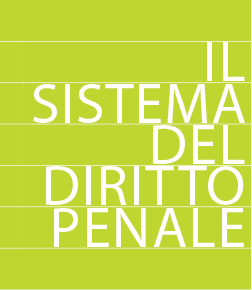La rilevanza del c.d. tempo silente per il superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari

Cass. Pen, Sez. V, 24 luglio 2025, n. 27295
LA MASSIMA
“In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose “storiche” (nella specie camorra), la valenza della dimensione temporale (ovvero “il tempo trascorso dai fatti”) non è fissa, omogenea, sempre uguale a se stessa, ma necessità di essere conformata rispetto al caso concreto, al tipo di sodalizio, alla qualità ed alla durata della partecipazione, alla “storia” dell’indagato, alla personalità del soggetto nei cui confronti deve essere compiuta la valutazione sull’adeguatezza della misura cautelare in corso e sulla esistenza di elementi rivelatori del superamento della presunzione di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. “.
IL CASO
A seguito di annullamento con rinvio da parte della Cassazione, il Tribunale del Riesame confermava, con ordinanza, la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di due soggetti accusati del delitto di cui all’art. 416-bis c.p., per la loro presunta appartenenza ad un noto clan operante nell’area campana, poiché riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e la presunzione di esigenze cautelari.
Contro tale decisione, gli indagati, a mezzo dei propri difensori proponevano ricorso per cassazione, sostenendo l’inesistenza delle esigenze cautelari.
In particolare, entrambi gli indagati hanno evidenziato che la loro condotta associativa si arrestava nel 2018.
Inoltre, uno dei due indagati, con distinti motivi di impugnazione, ha anche rappresentato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia erano riferite al periodo temporale 2009-2018;che era assente l’individuazione specifica di reati-fine; che non c’era stata partecipazione a ulteriori attività delittuose o indagini successive; che era intervenuta l’adozione, per reati affini, della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari o dell’annullamento di altre ordinanze cautelari; che vi era la necessità di retrodatazione dei termini di custodia cautelare sulla base della connessione tra il reato associativo e un precedente procedimento per tentata estorsione aggravata; Con motivi nuovi, la difesa invocava inoltre la rilevanza del c.d. tempo silente, richiamando orientamenti giurisprudenziali più aperti al suo riconoscimento come indice dell’assenza di attualità del pericolo, e, sul punto, in subordine, chiedeva la rimessione alle Sezioni Unite.
LA QUESTIONE
La Corte è chiamata a pronunciarsi sul dibattito interpretativo avente a oggetto la rilevanza del c.d. tempo silente (ossia dello iato temporale tra i fatti in contestazione e il momento dell’applicazione della misura cautelare): se è, di per sé solo, sufficiente a far cadere la presunzione di pericolosità prevista dall’art. 275, c. 3, c.p.p., per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose storiche, ovvero se, secondo l’orientamento di legittimità più rigoroso (v. Cass. Sez. 5, n. 16434/2024; in senso conforme, Cass. Sez. 2, n. 38848 /2021; Cass., Sez, 5, n. 36389/2019), può dirsi superato solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o dalla disarticolazione dell’associazione di riferimento.
LA SOLUZIONE
Anzitutto, quanto ai vincoli decisori derivanti dal giudizio rescindente, la Corte ricostruisce il perimetro decisorio che vincola il giudice del rinvio, distinguendo a seconda della natura del vizio rilevato nel provvedimento impugnato: in caso di violazione o erronea applicazione della legge, il giudice del rinvio è vincolato ai principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, con esclusione di ulteriori valutazioni in fatto (v. Cass., Sez. 2, n. 33560/2023); invece, in caso di vizi motivazionali, il giudice del rinvio conserva la libertà di compiere un nuovo apprezzamento probatorio, a condizione di evitare la reiterazione dei vizi riscontrati (v. ex multis, Cass. Sez. 5, n. 24133/2022; Sez. 6, n. 19206/2013).
Nel caso in esame, la sentenza rescindente aveva rilevato l’erronea applicazione dell’art. 275, co. 3, c.p.p., per avere, il Tribunale, escluso le esigenze cautelari sulla sola base del tempo trascorso, senza considerare il vincolo presuntivo previsto dalla norma in relazione al reato di partecipazione a organizzazione mafiosa.
Ne discende che il Tribunale del rescissorio era tenuto ad attenersi all’orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui la presunzione cautelare relativa prevista dall’art. 275, co. 3, c.p.p., in relazione al reato di cui all’art. 416-bis c.p., può essere superata solo in presenza di elementi obiettivi e concreti idonei a dimostrare la cessazione della pericolosità, non potendo attribuirsi valore dirimente al solo decorso temporale.
Invero, il cuore della decisione verte sul sull’interpretazione sistematica dell’art. 275, co. 3, c.p.p., alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, della riforma introdotta con la legge n. 47/2015 e dei principi costituzionali e convenzionali in materia di misure coercitive.
Per quanto attiene il contenuto della presunzione l’art. 275, co. 3, c.p.p. introduce, per i delitti più gravi (tra cui il 416-bis c.p.), una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, la quale opera iuris tantum, imponendo l’applicazione della misura carceraria salva la dimostrazione contraria da parte dell’indagato o dell’imputato. Essa costituisce uno strumento di tutela anticipata dell’ordine pubblico, giustificata dalla natura allarmante del reato e dal pericolo insito nella stabilità dei sodalizi criminali di tipo mafioso.
In questo contesto si inserisce il contrasto giurisprudenziale sull’efficacia del tempo silente.
La Corte, infatti, dà atto dell’esistenza di tre distinti orientamenti giurisprudenziali sulla possibilità di superamento della presunzione cautelare mediante il decorso del tempo (“tempo silente”):
L’orientamento più rigoroso e prevalente afferma che il decorso del tempo non è idoneo, di per sé solo, a superare la presunzione. Occorre la prova positiva del recesso dell’indagato dal sodalizio o della sua disarticolazione definitiva, una dimostrazione in modo obiettivo e concreto di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (Cass. Sez. 5, n. 16434/2024; Sez. 2, n. 38848/2021). Il tempo, dunque, può avere valenza meramente residuale, se accompagnato da elementi oggettivi (es. il trasferimento, in altra zona territoriale, la dissociazione, un’attività di collaborazione, assenza di recidive), ciò in quanto la presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali di cui all’art. 274 c.p.p.
Viceversa, l’orientamento più flessibile (minoritario, ma assunto da recenti pronunzie della Corte) asserisce, alla luce della legge n. 47/2015, che ha imposto la valutazione della concretezza e attualità del periculum libertatis, il decorso di un notevole lasso temporale, in assenza di nuove condotte sintomatiche di pericolosità, può concorrere a vincere la presunzione, pur in assenza di prova piena del recesso (Cass. Sez. 6, n. 11735/2024; Sez. 6, n. 31587/2023; Sez. 3, n. 6284/2019), insieme a una valutazione della storia e della personalità dell’indagato (v. Cass., Sez. 6, n. 4920/2024, dep. 2025; fr. Cass., Sez. Un. “Guttuso” in tema di pericolosità qualificata).
Vi è, inoltre, un orientamento intermedio, il quale sostiene che la presunzione relativa impone al giudice un criterio rafforzato di cautela: il tempo silente è rilevante solo se idoneo a superare ogni dubbio ragionevole sulla persistenza della pericolosità, alla luce del ruolo svolto, della durata della partecipazione e del contesto associativo (Cass. Sez. 2, n. 19341/2017; Sez. 6, n. 53028/2017).
Nel caso di specie, la Cassazione ritiene che il contrasto sia solo apparente: la presunzione non può essere neutralizzata dal solo decorso del tempo, ma nemmeno esclude a priori il rilievo del fattore temporale, che deve essere valutato in rapporto alla storia individuale dell’indagato, alla struttura del sodalizio e al grado di inserimento.
La valenza del “tempo silente” è dunque relativa e contestualizzata: assume significato solo se corredata da elementi sintomatici del distacco dalla criminalità organizzata (prima detenzione, assenza di recidive, mancato ruolo di vertice, riorientamento esistenziale documentato).
La Corte rileva come i ricorrenti non abbiano fornito alcun elemento concreto in grado di attestare un effettivo allontanamento dal sodalizio mafioso. Al contrario, la motivazione del Tribunale del riesame valorizza: la persistenza di un ruolo attivo all’interno del clan (partecipazione a summit, distribuzione dello “stipendio” mafioso, incarichi operativi per le estorsioni); la pluralità di condanne pregresse (rapine, sequestro, armi, furto, tentato omicidio); la recente condanna uno degli indagati per tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. (commessa nel 2019); l’esistenza di ulteriori titoli custodiali, sebbene poi annullati.
Ne consegue che l’evocato “tempo silente” non ha natura esimente, in assenza di circostanze individualizzate tali da scalzare la presunzione legale, che nella specie è rafforzata dalla gravità della condotta e dalla stabilità del vincolo associativo.
La Corte rigetta i ricorsi, ribadendo che in materia di custodia cautelare per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, la presunzione di esigenze cautelari ex art. 275, co. 3, c.p.p. può essere superata solo alla presenza di elementi obiettivi, specifici e concreti, idonei a dimostrare l’effettivo e irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio criminale. Il mero decorso del tempo, ove non sorretto da tali indicatori, non è sufficiente a vulnerare il giudizio di pericolosità.
Nota a cura di Valentina Musorrofiti